Lemon Twist and Olives
Profumato, acidulo, trasparente, alcolico e freddo gelato. E' il blog di Luca B Fornaroli
domenica 27 novembre 2016
Living room: lo spazio dove si vive. 2a parte.
L'uomo e l'ambiente: una liaison dangereuse
A questo punto diventa importante capire come noi, in quanto persone, ci relazioniamo con questi spazi, come interagiamo con essi una volta che abbiamo contribuito alla loro de-finizione cioè, letteralmente, al tracciamento dei loro confini, anche solo limitatamente alla disposizione delle cose sul nostro tavolo in ufficio o nel nostro armadietto. Come l'osservatore dei tagli di Fontana, dovremmo cercare di capire se subiamo o invece creiamo lo spazio circostante, se lo contempliamo quasi religiosamente nella sua bellezza o se lo riempiamo con la nostra vitale presenza, in uno sforzo teso a una maggiore consapevolezza del nostro ruolo, del bisogno che abbiamo di ordine o di disordine, di spazi vuoti o pieni e della coerenza tra l'ambiente in cui ci muoviamo e del modo in cui l'abbiamo trasformato e i nostri desideri e aspirazioni. In altre parole, molto semplici e semplicistiche: perché se amo l'ordine e l'armonia, vivo nel disordine e creo continuamente confusione? Perché se sono attratto dal kósmos creo il chàos intorno a me? Perché se sono un persona a cui piacciono i progetti e confido in un futuro più soddisfacente, mi crogiolo invece a contatto coi ricordi di un brutto passato? In estrema sintesi, domande come queste sono riassumibili in un unico interrogativo: se cioè lo spazio intorno a noi rifletta quello che siamo o invece rappresenti la persona che vorremmo essere.
Riflettere su che cosa vogliamo dall'ambiente in cui viviamo e operiamo, da cui fuggiamo o che ricerchiamo nel nostro tempo libero, ci aiuta a scoprire le radici delle nostre apparenti non scelte e ci aiuta a prendere le decisioni per modificarle o confermarle. Già cambiare lo spazio, segmentarlo diversamente, liberarlo dalle troppe cose presenti, ordinarlo secondo una regola che abbiamo deciso autonomamente e che non necessariamente debba seguire le convenzioni sociali, può rivelarsi uno straordinario strumento di cambiamento interiore. Agisco su di me attraverso l'azione sullo spazio intorno a me. L'intervento sull'ambiente in cui si vive apre le opzioni per realizzare gradatamente anche un cambiamento interiore, per diventare quella persona che si è deciso di essere se essa rappresenta per noi ancora una pienezza di significati e non è invece solo il prodotto di condizionamenti, mode, conformismi. Tuttavia, affinché il rapporto con lo spazio sia consapevole e possa aiutarci a cambiare o a confermarci nelle nostre scelte, dobbiamo alimentarlo, renderlo oggetto di attenzioni costanti, non solo di un'iniziativa una tantum frutto casuale di una giornata particolarmente creativa. Si ritorna così all'estetica giapponese da cui siamo partiti: l'ambiente esige cure, non diversamente da un bonsai o da qualsiasi realtà vivente. Cure attraverso cui manifestiamo la nostra personalità agli altri, ma soprattutto a noi stessi: un quotidiano coltivare la propria libertà attraverso piccoli compiti che ricostruiscano o proteggano l'armonia dello spazio in cui viviamo e che ci deve rappresentare anche attraverso il disordine se è il disordine quello che vogliamo perché siamo stufi di una vita troppo piena di regole ed etichette. L'armonia deve essere tra l'ambiente esterno e la nostra interiorità e non tanto tra gli oggetti, se non è l'armonia tra gli oggetti quello di cui abbiamo bisogno e che ci interessa. La cura, le attenzioni sono volte quindi a proteggere quel confine fragile che corre tra l'ambiente come luogo dove esprimiamo la nostra libertà e l'ambiente che ci ossessiona con i suoi obblighi, la frustrazione dei lavori domestici o dell'attività professionale, l'oppressioni delle relazioni sociali e persino familiari. Occuparsi dello spazio intorno a noi non deve significare quindi crearsi un'altra gabbia da dover tenere pulita, ma poterci muovere e vivere in un luogo fisico e simbolico che ci sia congeniale, che sentiamo finalmente come nostro, attraversato anche dal nostro spirito, frutto della nostra libertà e di quella di coloro che vivono con noi.
L'estraneità dell'ambiente di lavoro
Un'analoga riflessione può essere condotta su un piano meno esistenziale, ma non per questo meno condizionante, qual è quello rappresentato dall'ambiente di lavoro, soprattutto se è uno spazio che altri hanno voluto, organizzato e di cui hanno deciso le regole. Il contesto organizzativo è caratterizzato da rapporti più superficiali e temporanei rispetto a quelli che definiscono la natura del nostro ambiente privato. Tuttavia, tale superficialità riesce a esercitare un impatto molto profondo sul nostro benessere, sull'immagine che abbiamo di noi stessi e persino sull'ambiente dove viviamo. La costrizione della nostra libertà che subiamo al di fuori del nostro spazio ideale inevitabilmente si ripercuote su quest'ultimo, trasformandolo o nel buen retiro dove possiamo riprendere confidenza con noi stessi o nello specchio impietoso delle nostre frustrazioni e incapacità di dare una direzione alla nostra vita. Il rapporto tra gli spazi dove viviamo è sempre interdipendente e noi siamo il trait d'union tra tutti loro: è una pia illusione, un autoinganno, credere di poter "chiudere saracinesche" o creare compartimenti stagni. Si può solo cercare di migliorare la relazione con i vari ambienti trasferendo il bene, il buono e il bello dall'uno all'altro nei limiti delle nostre possibilità.
Una buona gestione manageriale non può sottovalutare l'importanza dell'ambiente sulle persone/risorse che lo occupano e su come questo possa condizionare il loro lavoro in termini di creatività, originalità, responsabilità ed efficacia. Il dogma e il falso mito dell'efficienza sembra invece prediligere ambienti freddi, dis-umani, illuminati male, aerati in modo artificiale e malsano, arredati con mobili freddi, poveri, ma costosi, che puzzano di colle tossiche e formaldeide. Siamo tornati molto indietro rispetto al modello di azienda che un gigante come Adriano Olivetti cercò di realizzare, in cui l'ambiente di lavoro potesse diventare luogo di crescita e di benessere per le persone.
Senza voler seguire la complessa filosofia olivettiana, basta veramente poco per creare uno spazio in cui
lavorare più decentemente: per esempio, basta coinvolgere, prima delle decisioni di arredo o di organizzazione degli ambienti, le persone che ci andranno a lavorare, che spenderanno lì otto ore al giorno della loro vita. Capirne le esigenze e i bisogni e cercare di venire loro incontro significa costruire un progetto comune di cui tutti sono responsabili e di cui tutti accettano gli inevitabili compromessi con più facilità. Non si tratta di essere utopisti o particolarmente illuminati, c'è già qualche interessante caso del genere in Italia come l'ambiziosa struttura di Zambon progettata da De Lucchi a Bresso con il coinvolgimento del personale. In quel caso sono stati investiti milioni, ma il principio può essere realizzato con una minima spesa, spesso inferiore a quella che qualche consulente può aver preventivato per la realizzazione di una struttura dove lui peraltro non metterebbe mai piede.
Corpo e scrittura
Un'ultima annotazione che non vuol essere ironica e che torna alle tematiche esistenziali e strettamente personali, evidenziando la straordinaria importanza dell'ambiente fisico. È curioso come quando si affrontano i disturbi alimentari in pochi si pongano il problema dello spazio: ci si concentra sul peso, ma raramente sul volume del corpo. Eppure la prima conseguenza visibile dell'obesità o della denutrizione volontaria è l'aumento o la riduzione del volume e quindi dello spazio occupato. Attraverso un'alimentazione eccessiva o insufficiente posso sia affermare la mia presenza, imponendomi agli altri, sia al contrario sparire dissolvendomi. Il rapporto con l'ambiente circostante diventa dalla nascita una perenne sfida tra l'affermazione e la negazione di sé, una rassicurazione circa la propria presenza o assenza di fisicità. È una relazione originaria e condizionante molti aspetti dell'esistenza, una matrice spesso per tutti gli altri tipi di rapporto di cui sono parte.
In conclusione di questo lungo excursus un po' impressionistico e poco sistematico sul rapporto tra spazio e individuo, merita di essere accennato un paragone con la scrittura. Scrivere, a mano, è muoversi su uno spazio vuoto dando vita a segni che lo suddividono e gli conferiscono significato. La lettera, la parola e infine il testo scritto, non solo riempiono lo spazio del foglio, ma lo ampliano con i contenuti che esprimono, siano anche solo una lista della spesa o delle cose da fare. Un rettangolo bidimensionale diventa così una pluralità di realtà diverse, di oggetti da acquistare al supermercato o di commissioni da portare a termine, persone da incontrare, luoghi verso cui dirigersi: si formano insomma altre dimensioni che trascendono quello spazio vuoto iniziale.
Non diversamente, interagendo anche fisicamente col nostro ambiente, abbiamo il potere di conferirgli nuovi significati, arricchirlo di nuove estese potenzialità, trovare in esso nuovi ambiti e possibilità esistenziali, ridisegnando così il rapporto con noi stessi e con gli altri.
martedì 22 novembre 2016
Living Room: lo spazio dove si vive. 1a parte.
Premessa in compagnia di Lucio Fontana
 La recente visita allo showroom di oggetti e mobili di design di varie epoche che Daniele Cislaghi è riuscito ad allestire ad Abbiategrasso, grazie ad anni di ricerca e di contatti in tutto il mondo, mi dà lo spunto per qualche riflessione sul nostro rapporto con lo spazio dove viviamo. Innanzitutto osservo con piacere che un'esposizione di begli oggetti in un ambiente curato e opportunamente studiato contribuisce all'innalzamento dell'attenzione per la cultura materiale in un'area del milanese tradizionalmente sonnecchiante e piuttosto arida. Uno spazio privato che diventa per la sua stessa presenza una ricchezza comune e che sarebbe perfetto per ospitare iniziative coerenti con lo spirito che lo anima.
La recente visita allo showroom di oggetti e mobili di design di varie epoche che Daniele Cislaghi è riuscito ad allestire ad Abbiategrasso, grazie ad anni di ricerca e di contatti in tutto il mondo, mi dà lo spunto per qualche riflessione sul nostro rapporto con lo spazio dove viviamo. Innanzitutto osservo con piacere che un'esposizione di begli oggetti in un ambiente curato e opportunamente studiato contribuisce all'innalzamento dell'attenzione per la cultura materiale in un'area del milanese tradizionalmente sonnecchiante e piuttosto arida. Uno spazio privato che diventa per la sua stessa presenza una ricchezza comune e che sarebbe perfetto per ospitare iniziative coerenti con lo spirito che lo anima.
Muovermi in quelle sale mi ha nuovamente fatto pensare ai Concetti spaziali di Lucio Fontana, i suoi tagli nelle tele. Fontana squarcia la bidimensionalità monocroma della tela con tagli secchi, affilati, netti, che sembrano aprire il varco a una nuova dimensione sottostante. Il taglio apre lo spazio chiuso, confinato, della tela. Sotto di essa appare un mondo imperscrutabile o, meglio, solo perscrutabile dalle fessure create, un mondo nero d'ombra, una meta-realtà davanti alla quale l'osservatore non sa più se egli è ancora il soggetto che osserva o se diventa l'oggetto che viene osservato da qualcuno indefinibile e non identificabile che lo guarda al di là dei tagli. È veramente affascinante come la semplice azione del guardare un'opera - un gesto spesso passivo e inconsapevole - possa condurre lontano, verso un'involontaria dimensione esistenziale. Chi sono io, un soggetto che pensa, riflette, decide e agisce liberamente o un povero prigioniero delle proprie convinzioni, ambizioni e abitudini, oggetto dello sguardo commiserevole di qualcuno che neanche riesco a vedere? Sempre, l'arte - quella vera - riesce a parlare senza intermediazioni al nostro cervello e alla nostra pancia in modo imprevedibile e inaspettato.
Lo spazio e le cose: dalla Toscana al Giappone
In inglese il salotto si chiama living room, cioè lo spazio dove viviamo, in cui siamo più genuinamente noi stessi, dove ci riposiamo, leggiamo, scriviamo, ci intratteniamo coi familiari e riceviamo i nostri ospiti. Lo spazio dove la nostra personalità si manifesta, dove diventiamo soggetti. Lo spazio che noi stessi abbiamo disegnato, arredato, riempito. Non è possibile vivere senza una costante dialettica con lo spazio circostante:
una dialettica dinamica, che muta in continuazione. Il nostro muoverci modifica lo spazio intorno e lo spazio condiziona il nostro movimento. Non siamo mai quindi nello stesso posto anche se ci torniamo decine di volte al giorno. Proprio come non riusciamo a bagnarci due volte nelle stesse acque del famoso fiume di Eraclito.
 Qualsiasi oggetto modifica lo spazio in cui è collocato, traccia alcune linee invisibili, cattura l'occhio verso se stesso: basti pensare a un albero nel mezzo di un paesaggio toscano o a un airone posato elegantemente tra due risaie. Senza quei testimoni il paesaggio muta di significato, diventa meno visibile, non colpisce la nostra attenzione. Una stanza vuota dalle pareti bianche è qualcosa di essenzialmente diverso dalla stessa stanza in cui dal soffitto penda una scultura di Calder, coi suoi colori, il suo muoversi all'aria, al nostro passaggio, come rami e foglie leggere. La stanza stessa sembra muoversi, ingrandirsi, avere una funzione che le conferisce senso.
Qualsiasi oggetto modifica lo spazio in cui è collocato, traccia alcune linee invisibili, cattura l'occhio verso se stesso: basti pensare a un albero nel mezzo di un paesaggio toscano o a un airone posato elegantemente tra due risaie. Senza quei testimoni il paesaggio muta di significato, diventa meno visibile, non colpisce la nostra attenzione. Una stanza vuota dalle pareti bianche è qualcosa di essenzialmente diverso dalla stessa stanza in cui dal soffitto penda una scultura di Calder, coi suoi colori, il suo muoversi all'aria, al nostro passaggio, come rami e foglie leggere. La stanza stessa sembra muoversi, ingrandirsi, avere una funzione che le conferisce senso.
La delicata eleganza degli interni delle case giapponesi, così mutevoli grazie all'uso delle pareti scorrevoli, così funzionali a un ideale estetico che sembra improntato al rispetto: un ambiente rarefatto in cui le poche cose tuttavia impongono rispettosamente la loro silenziosa presenza. In cui le persone - come già fece notare Bruno Munari in "Arte come mestiere" - non possono lasciarsi andare a comportamenti fuori misura, perché l'ambiente di carta di riso e listelli di legno rischierebbe di venirne danneggiato. L'armonia si spezzerebbe; quella stessa armonia che trova una sua straordinaria espressione nel tokonoma, l'angolo della casa destinato ad accogliere una pianta, un vaso, un pannello disegnato o una pergamena che ne fanno una sorta di altare laico, naturalistico e spirituale.
La casa e la "strada"
Per contrasto, invece, immaginiamo quelle case - spesso le nostre - piene di oggetti accumulatisi quasi a caso, senza una legge, frutto di viaggi, esperienze, ricordi, disattenzioni. Oggetti che sembrano dover riempire un vuoto e che ci impediscono di muoverci comodamente, ma che tuttavia talvolta hanno il potere di aprire spazi mentali, in cui ritroviamo noi stessi nella memoria di quell'incontro, quell'affetto, quell'avventura di cui non ci resta altro che una foto, un souvenir, un frammento di pensiero ed emozioni. Le persone anziane soprattutto fanno di questi spazi mentali - che si aprono nel vedere o toccare uno dei loro oggetti consumati dal tempo - una nuova dimensione vitale: lo spazio fisico che riescono a percorre con gli anni è destinato a ridursi, i movimenti si accorciano e si rallentano, ma una nuova comfort zone domestica prende forma in cui le coordinate dello spazio e del tempo si sovrappongono; un ricordo è infatti sempre anche un luogo, un'atmosfera, un orizzonte che non ha nulla ha che fare con quello che essi vedono al di fuori della finestra o al di dentro del tubo catodico.
 Le case dove abitiamo o gli uffici dove lavoriamo sono segmentazioni dello spazio sia interno sia esterno. All'interno, l'ambiente ha in molti casi destinazioni specifiche legate alle persone, non solo alle funzioni: la camera dei genitori, quelle dei figli, la scrivania del collega, la sedia a tavola in cui si siede "solo" il nonno. Violare queste attribuzioni non di rado crea scompiglio, conflitto. Quel piccolo spazio è percepito come parte integrante della nostra personalità, vederselo sottratto è sentito come violenza, sopruso.
Le case dove abitiamo o gli uffici dove lavoriamo sono segmentazioni dello spazio sia interno sia esterno. All'interno, l'ambiente ha in molti casi destinazioni specifiche legate alle persone, non solo alle funzioni: la camera dei genitori, quelle dei figli, la scrivania del collega, la sedia a tavola in cui si siede "solo" il nonno. Violare queste attribuzioni non di rado crea scompiglio, conflitto. Quel piccolo spazio è percepito come parte integrante della nostra personalità, vederselo sottratto è sentito come violenza, sopruso.
All'esterno, la casa pone i confini tra il nostro spazio privato, quello altrui (i vicini, ad esempio) e quello pubblico. È la casa che fa sì che ci sia un dentro e un fuori, un noi e un loro. La casa può essere pertanto rifugio, protezione, laboratorio, conforto, ma anche tana, prigione, disimpegno, indifferenza. Giorgio Gaber anni fa scrisse una meravigliosa canzone, C'è solo la strada (https://youtu.be/OBthTGY-zZs), in cui, evidenziando i rischi del chiudersi in casa, nel proprio particulare, enfatizzava invece l'importanza della strada come luogo di incontro, di sviluppo della personalità e di crescita della società. La casa aperta è un'efficace metafora di questo bisogno non solo di protezione, ma anche di partecipazione, di confronto. Le splendide architetture di Mies van der Rohe sono il più bell'esempio di spazio domestico dove il confine tra dentro e fuori è indefinibile, di una casa che grazie alle immense pareti vetrate si apre al mondo e alla natura e li fa entrare.
(continua)
 La recente visita allo showroom di oggetti e mobili di design di varie epoche che Daniele Cislaghi è riuscito ad allestire ad Abbiategrasso, grazie ad anni di ricerca e di contatti in tutto il mondo, mi dà lo spunto per qualche riflessione sul nostro rapporto con lo spazio dove viviamo. Innanzitutto osservo con piacere che un'esposizione di begli oggetti in un ambiente curato e opportunamente studiato contribuisce all'innalzamento dell'attenzione per la cultura materiale in un'area del milanese tradizionalmente sonnecchiante e piuttosto arida. Uno spazio privato che diventa per la sua stessa presenza una ricchezza comune e che sarebbe perfetto per ospitare iniziative coerenti con lo spirito che lo anima.
La recente visita allo showroom di oggetti e mobili di design di varie epoche che Daniele Cislaghi è riuscito ad allestire ad Abbiategrasso, grazie ad anni di ricerca e di contatti in tutto il mondo, mi dà lo spunto per qualche riflessione sul nostro rapporto con lo spazio dove viviamo. Innanzitutto osservo con piacere che un'esposizione di begli oggetti in un ambiente curato e opportunamente studiato contribuisce all'innalzamento dell'attenzione per la cultura materiale in un'area del milanese tradizionalmente sonnecchiante e piuttosto arida. Uno spazio privato che diventa per la sua stessa presenza una ricchezza comune e che sarebbe perfetto per ospitare iniziative coerenti con lo spirito che lo anima.Muovermi in quelle sale mi ha nuovamente fatto pensare ai Concetti spaziali di Lucio Fontana, i suoi tagli nelle tele. Fontana squarcia la bidimensionalità monocroma della tela con tagli secchi, affilati, netti, che sembrano aprire il varco a una nuova dimensione sottostante. Il taglio apre lo spazio chiuso, confinato, della tela. Sotto di essa appare un mondo imperscrutabile o, meglio, solo perscrutabile dalle fessure create, un mondo nero d'ombra, una meta-realtà davanti alla quale l'osservatore non sa più se egli è ancora il soggetto che osserva o se diventa l'oggetto che viene osservato da qualcuno indefinibile e non identificabile che lo guarda al di là dei tagli. È veramente affascinante come la semplice azione del guardare un'opera - un gesto spesso passivo e inconsapevole - possa condurre lontano, verso un'involontaria dimensione esistenziale. Chi sono io, un soggetto che pensa, riflette, decide e agisce liberamente o un povero prigioniero delle proprie convinzioni, ambizioni e abitudini, oggetto dello sguardo commiserevole di qualcuno che neanche riesco a vedere? Sempre, l'arte - quella vera - riesce a parlare senza intermediazioni al nostro cervello e alla nostra pancia in modo imprevedibile e inaspettato.
Lo spazio e le cose: dalla Toscana al Giappone
In inglese il salotto si chiama living room, cioè lo spazio dove viviamo, in cui siamo più genuinamente noi stessi, dove ci riposiamo, leggiamo, scriviamo, ci intratteniamo coi familiari e riceviamo i nostri ospiti. Lo spazio dove la nostra personalità si manifesta, dove diventiamo soggetti. Lo spazio che noi stessi abbiamo disegnato, arredato, riempito. Non è possibile vivere senza una costante dialettica con lo spazio circostante:
una dialettica dinamica, che muta in continuazione. Il nostro muoverci modifica lo spazio intorno e lo spazio condiziona il nostro movimento. Non siamo mai quindi nello stesso posto anche se ci torniamo decine di volte al giorno. Proprio come non riusciamo a bagnarci due volte nelle stesse acque del famoso fiume di Eraclito.
 Qualsiasi oggetto modifica lo spazio in cui è collocato, traccia alcune linee invisibili, cattura l'occhio verso se stesso: basti pensare a un albero nel mezzo di un paesaggio toscano o a un airone posato elegantemente tra due risaie. Senza quei testimoni il paesaggio muta di significato, diventa meno visibile, non colpisce la nostra attenzione. Una stanza vuota dalle pareti bianche è qualcosa di essenzialmente diverso dalla stessa stanza in cui dal soffitto penda una scultura di Calder, coi suoi colori, il suo muoversi all'aria, al nostro passaggio, come rami e foglie leggere. La stanza stessa sembra muoversi, ingrandirsi, avere una funzione che le conferisce senso.
Qualsiasi oggetto modifica lo spazio in cui è collocato, traccia alcune linee invisibili, cattura l'occhio verso se stesso: basti pensare a un albero nel mezzo di un paesaggio toscano o a un airone posato elegantemente tra due risaie. Senza quei testimoni il paesaggio muta di significato, diventa meno visibile, non colpisce la nostra attenzione. Una stanza vuota dalle pareti bianche è qualcosa di essenzialmente diverso dalla stessa stanza in cui dal soffitto penda una scultura di Calder, coi suoi colori, il suo muoversi all'aria, al nostro passaggio, come rami e foglie leggere. La stanza stessa sembra muoversi, ingrandirsi, avere una funzione che le conferisce senso.La delicata eleganza degli interni delle case giapponesi, così mutevoli grazie all'uso delle pareti scorrevoli, così funzionali a un ideale estetico che sembra improntato al rispetto: un ambiente rarefatto in cui le poche cose tuttavia impongono rispettosamente la loro silenziosa presenza. In cui le persone - come già fece notare Bruno Munari in "Arte come mestiere" - non possono lasciarsi andare a comportamenti fuori misura, perché l'ambiente di carta di riso e listelli di legno rischierebbe di venirne danneggiato. L'armonia si spezzerebbe; quella stessa armonia che trova una sua straordinaria espressione nel tokonoma, l'angolo della casa destinato ad accogliere una pianta, un vaso, un pannello disegnato o una pergamena che ne fanno una sorta di altare laico, naturalistico e spirituale.
La casa e la "strada"
Per contrasto, invece, immaginiamo quelle case - spesso le nostre - piene di oggetti accumulatisi quasi a caso, senza una legge, frutto di viaggi, esperienze, ricordi, disattenzioni. Oggetti che sembrano dover riempire un vuoto e che ci impediscono di muoverci comodamente, ma che tuttavia talvolta hanno il potere di aprire spazi mentali, in cui ritroviamo noi stessi nella memoria di quell'incontro, quell'affetto, quell'avventura di cui non ci resta altro che una foto, un souvenir, un frammento di pensiero ed emozioni. Le persone anziane soprattutto fanno di questi spazi mentali - che si aprono nel vedere o toccare uno dei loro oggetti consumati dal tempo - una nuova dimensione vitale: lo spazio fisico che riescono a percorre con gli anni è destinato a ridursi, i movimenti si accorciano e si rallentano, ma una nuova comfort zone domestica prende forma in cui le coordinate dello spazio e del tempo si sovrappongono; un ricordo è infatti sempre anche un luogo, un'atmosfera, un orizzonte che non ha nulla ha che fare con quello che essi vedono al di fuori della finestra o al di dentro del tubo catodico.
 Le case dove abitiamo o gli uffici dove lavoriamo sono segmentazioni dello spazio sia interno sia esterno. All'interno, l'ambiente ha in molti casi destinazioni specifiche legate alle persone, non solo alle funzioni: la camera dei genitori, quelle dei figli, la scrivania del collega, la sedia a tavola in cui si siede "solo" il nonno. Violare queste attribuzioni non di rado crea scompiglio, conflitto. Quel piccolo spazio è percepito come parte integrante della nostra personalità, vederselo sottratto è sentito come violenza, sopruso.
Le case dove abitiamo o gli uffici dove lavoriamo sono segmentazioni dello spazio sia interno sia esterno. All'interno, l'ambiente ha in molti casi destinazioni specifiche legate alle persone, non solo alle funzioni: la camera dei genitori, quelle dei figli, la scrivania del collega, la sedia a tavola in cui si siede "solo" il nonno. Violare queste attribuzioni non di rado crea scompiglio, conflitto. Quel piccolo spazio è percepito come parte integrante della nostra personalità, vederselo sottratto è sentito come violenza, sopruso.All'esterno, la casa pone i confini tra il nostro spazio privato, quello altrui (i vicini, ad esempio) e quello pubblico. È la casa che fa sì che ci sia un dentro e un fuori, un noi e un loro. La casa può essere pertanto rifugio, protezione, laboratorio, conforto, ma anche tana, prigione, disimpegno, indifferenza. Giorgio Gaber anni fa scrisse una meravigliosa canzone, C'è solo la strada (https://youtu.be/OBthTGY-zZs), in cui, evidenziando i rischi del chiudersi in casa, nel proprio particulare, enfatizzava invece l'importanza della strada come luogo di incontro, di sviluppo della personalità e di crescita della società. La casa aperta è un'efficace metafora di questo bisogno non solo di protezione, ma anche di partecipazione, di confronto. Le splendide architetture di Mies van der Rohe sono il più bell'esempio di spazio domestico dove il confine tra dentro e fuori è indefinibile, di una casa che grazie alle immense pareti vetrate si apre al mondo e alla natura e li fa entrare.
(continua)
mercoledì 28 settembre 2016
La Pietà Rondanini: cinquecento anni di arte contemporanea.
 La Pietà Rondanini - dal nome della famiglia venuta in suo possesso anni dopo la morte di Michelangelo - è uno straordinario capolavoro di arte contemporanea, realizzato però cinquecento anni prima degli albori dell'arte contemporanea. Un'opera che sarebbe perfettamente coerente e a proprio agio con le sue nipotine della Collezione Guggenheim, della Fondazione Maeght o del museo del Novecento a Milano.
La Pietà Rondanini - dal nome della famiglia venuta in suo possesso anni dopo la morte di Michelangelo - è uno straordinario capolavoro di arte contemporanea, realizzato però cinquecento anni prima degli albori dell'arte contemporanea. Un'opera che sarebbe perfettamente coerente e a proprio agio con le sue nipotine della Collezione Guggenheim, della Fondazione Maeght o del museo del Novecento a Milano.Da profano e semplice curioso, sono sempre stato nel contempo attratto e respinto dalla sua indecifrabilità, incompiutezza e - ai miei occhi - incomprensibilità. Non capivo perché Michelangelo, che già aveva fatto sessant'anni prima una pietà bellissima in San Pietro, avesse dovuto cimentarsi in un simile "sgorbio". Come molti, ho sempre dato per scontata la sua natura di opera incompleta, iniziata, interrotta e mai finita. Una Pietà anomala, inquietante, che per molto tempo mi evocava qualcosa di simile al salvataggio di un naufrago, parendomi la Madonna più somigliante a un pescatore misericordioso e Gesù a qualcuno che veniva raccolto esanime dall'acqua. La pietà, appunto, del soccorritore, del salvatore che salva il Salvatore. Oppure, con mente paganeggiante, vedevo in essa il pensiero di Nausicaa davanti a Ulisse, desiderosa nel corpo di prendersene cura o quello di Odisseo-Nessuno davanti alla figlia del re dei Feaci, desideroso di abbandonarsi, sfinito, alla sua accoglienza e benevolenza. Una macedonia di sensazioni e reminiscenze scolastiche che hanno contribuito al non poter essere indifferente rispetto a una specie di mistero marmoreo, di racconto ermetico scritto in punta di scalpello.
Solo molto recentemente tuttavia sono stato folgorato dalla sua straordinaria importanza e credo di averne colto almeno alcuni dei molti significati.
 Innanzitutto non è un'opera incompiuta - come ha anche rilevato Henry Moore in una sua originale analisi tecnica - è piuttosto un'opera voluta nella sua indeterminatezza. La scultura era già stata terminata dall'autore ed era completamente diversa da come ci appare ora: era un sublime esempio di arte rinascimentale che richiamava l'arte classica, ma con un tema a carattere religioso. Il Cristo deposto dalla croce e vegliato da sua madre piena di grazia e di pietà. Poi Michelangelo ha deciso di doverla cambiare, di distruggerla, di farla diventare altro. Di quella prima versione rimangono solo le gambe, così realistiche, eleganti, che sembrano nell'inerzia di sciogliersi dalla postura in cui erano costrette sulla croce. Il resto viene deturpato, modificato, come se Michelangelo fosse in cerca della vera anima di quell'opera: il lavoro di rimozione dell'inutile non trova mai compimento; l'immagine di madre e figlio è non umana, umbratile, stilizzata, quasi mera apparenza, un'epifania sempre più immateriale a mano a mano che dalle gambe ci si muove verso i volti. Michelangelo sembra voler così rappresentare il mistero irrappresentabile, il dio fatto uomo e sua madre, madre di dio. C'è una forza innaturale in quei tratti appena accennati, cancellati: presenze che sembrano lentamente svanire, perdersi nella materia o, al contrario, emergere dallo spazio, prendere forma sotto gli occhi dell'osservatore, inevitabilmente confuso, attonito. Il cristo uomo è morto e cambia natura, sostanza, svanisce nel marmo e da lì risorge. Questo tentativo di raffigurare il non raffigurabile è tipico dell'arte contemporanea, dove l'opera si definisce nell'immaginazione di chi la osserva. Basti pensare alle sculture di Boccioni che interpretano il dinamismo stando ferme e riescono a fare vedere il movimento dell'aria e della materia oppure al più volte citato Giacometti e all'indefinitezza delle sue forme e delle sue superfici, tese verso una perfezione che non possono mai raggiungere.
Innanzitutto non è un'opera incompiuta - come ha anche rilevato Henry Moore in una sua originale analisi tecnica - è piuttosto un'opera voluta nella sua indeterminatezza. La scultura era già stata terminata dall'autore ed era completamente diversa da come ci appare ora: era un sublime esempio di arte rinascimentale che richiamava l'arte classica, ma con un tema a carattere religioso. Il Cristo deposto dalla croce e vegliato da sua madre piena di grazia e di pietà. Poi Michelangelo ha deciso di doverla cambiare, di distruggerla, di farla diventare altro. Di quella prima versione rimangono solo le gambe, così realistiche, eleganti, che sembrano nell'inerzia di sciogliersi dalla postura in cui erano costrette sulla croce. Il resto viene deturpato, modificato, come se Michelangelo fosse in cerca della vera anima di quell'opera: il lavoro di rimozione dell'inutile non trova mai compimento; l'immagine di madre e figlio è non umana, umbratile, stilizzata, quasi mera apparenza, un'epifania sempre più immateriale a mano a mano che dalle gambe ci si muove verso i volti. Michelangelo sembra voler così rappresentare il mistero irrappresentabile, il dio fatto uomo e sua madre, madre di dio. C'è una forza innaturale in quei tratti appena accennati, cancellati: presenze che sembrano lentamente svanire, perdersi nella materia o, al contrario, emergere dallo spazio, prendere forma sotto gli occhi dell'osservatore, inevitabilmente confuso, attonito. Il cristo uomo è morto e cambia natura, sostanza, svanisce nel marmo e da lì risorge. Questo tentativo di raffigurare il non raffigurabile è tipico dell'arte contemporanea, dove l'opera si definisce nell'immaginazione di chi la osserva. Basti pensare alle sculture di Boccioni che interpretano il dinamismo stando ferme e riescono a fare vedere il movimento dell'aria e della materia oppure al più volte citato Giacometti e all'indefinitezza delle sue forme e delle sue superfici, tese verso una perfezione che non possono mai raggiungere.Il dato storico artistico dice che la seconda versione della Pietà è letteralmente e materialmente derivata dalla prima, dal blocco di marmo che ha liberato da sé la Pietà precedente. Michelangelo ha estratto la sua seconda opera da quella preesistente, sembra, scambiando le parti tra Gesù e Maria: ricavando la testa del secondo Gesù dal petto di Maria e la seconda Maria dal corpo di Cristo. In questa rappresentazione Gesù e Maria sono l'una parte dell'altro, si generano reciprocamente, non si limitano a condividere la materia di cui sono fatti. In questo modo Michelangelo riesce a esprimere almeno due concetti assai rilevanti anche sotto il profilo teologico: l'opera è una metamorfosi di un lavoro preesistente così come la morte di Cristo è una sorta di metamorfosi della sua natura: muore il Gesù uomo, si smaterializza e torna al padre. Il secondo concetto teologico - che io trovo straordinario - è l'unicità della natura e della materia di Cristo e della Madonna. Non più madre e figlio, ma un unico corpo, un'unica dimensione, un'unica natura in due incarnazioni. Un concetto forse eretico, ma di straordinaria forza: non solo dio-padre, ma dio-madre in un'unica materia col figlio. Ricordo che l'espressione Dio-Madre fu usata da Giovanni Paolo I nel suo brevissimo pontificato. Mi piace pensare - è una mia forzatura da ateo - che sia Michelangelo Buonarroti sia Albino Luciani potessero immaginare una trinità composta da Padre, Figlio e Madre. Del resto non sarebbe così azzardato con-fondere, fondere insieme, Maria e lo Spirito Santo persino in un ambito cattolico tradizionale.
Tuttavia Michelangelo non smette di riservare sorprese: basta osservare la Pietà secondo l'asse verticale. La rappresentazione marmorea del corpo morto di Gesù deposto dalla croce non sembra affatto raffigurare un morto, ma una sofferenza, uno svuotamento di energie, un'agonia, un involucro esterno abbandonato o, forse, qualcuno che invece si sta rialzando. Affinando l'attenzione tuttavia, il Cristo che esce dal petto di Maria (dal costato, quasi a voler rovesciare così il rapporto tra Adamo ed Eva) sembra significare una nuova nascita dopo la morte, un parto in una dimensione altra da quella umana. Nella Pietà la morte diventa metamorfosi e poi rinascita.
In molti ritengono che la statua fosse destinata a essere il monumento funerario della tomba di Michelangelo, ormai molto anziano. La morte sarebbe la sua morte, di uomo che invoca la pietà davanti alla fine. Può darsi, ma mi sembrerebbe un modo riduttivo di interpretare un'opera sconcertante. Se il suo significato non dovesse essere anche teologico, ma si limitasse alla fine dell'esistenza terrena dell'autore, anche in questo caso non si tratterebbe, secondo me, di una semplice invocazione della Misericordia in limine mortis, ma una concezione della morte come metamorfosi dell'uomo che viene accolto perché rinasca, abbandoni questa realtà corporea per raggiungere uno stato spirituale, epifanico, inafferrabile con l'intelletto. Così almeno mi piace pensarla, esoterica nel suo non essere afferrabile, spirituale in modo intimo, profondo, al di fuori da canoni e liturgie ecclesiastiche, misterica nel potersi offrire a tanti livelli di interpretazione, contemporanea nel rappresentare anche i gesti, i colpi, che l'hanno fatta emergere da un capolavoro precedente cancellato e rimodellato per darle vita. Non escluderei neppure, in virtù della personalità di Michelangelo, un intento di tipo politico: il manifesto scultoreo di un bisogno di rinnovamento radicale della chiesa, l'urgenza di abbandonare i fasti rinascimentali rappresentati dall'opera precedente e ritrovare la Via dello spirito, del dio fatto uomo, della morte e resurrezione, nella sua inafferrabile essenza. Non va sottovalutato infatti che il secolo della Pietà Rondanini è quello della Riforma e delle sue istanze.
 La Pietà Rondanini, conservata al Castello Sforzesco, a Milano è l'ultimo lavoro di Michelangelo, il suo epitaffio artistico. Mentre sessant'anni prima la Pietà di San Pietro fu il suo primo capolavoro di giovane scultore. Due opere che aprono e chiudono il ciclo di una vita eccezionale e che la eternano tra noi mortali.
La Pietà Rondanini, conservata al Castello Sforzesco, a Milano è l'ultimo lavoro di Michelangelo, il suo epitaffio artistico. Mentre sessant'anni prima la Pietà di San Pietro fu il suo primo capolavoro di giovane scultore. Due opere che aprono e chiudono il ciclo di una vita eccezionale e che la eternano tra noi mortali.
lunedì 12 settembre 2016
L'opera d'arte come strumento di formazione

(Viene qui di seguito riportato il testo del mio intervento a "Pitturazione: quando la formazione incontra l'arte", con l'esperto di processi formativi Cristiana Clementi e la pittrice Valentina Canale, Cassinetta di Lugagnano, Milano, 10 settembre 2016).
"L'arte è solo un mezzo per vedere", così si esprimeva lo scultore grigionese della indeterminatezza dell'uomo Alberto Giacometti. Sorprende una frase così netta, definita, quasi sminuente, da parte di un autore le cui opere sono invece la testimonianza di una incapacità di esprimersi in maniera definitiva, di raggiungere un risultato soddisfacente che non sia invece in continuo movimento, evoluzione, superamento di sé. "L'arte è solo un mezzo per vedere": non ci si può non chiedere davanti a un'affermazione del genere chi sia il soggetto vedente e quale l'oggetto visto. Così come non si può fare a meno di pensare all'arte come strumento, mezzo di intermediazione della conoscenza, molto lontana quindi dall'idea di ars gratia artis - l'arte per l'arte - con cui ci hanno riempito la testa a scuola: il culto dell'arte, una religione estetica neopagana, una categoria dello spirito.
 L'appunto di Giacometti invece ci trasmette l'idea affascinante di un'arte da imparare a capire, a usare, per vedere la realtà. L'oggetto dell'arte, il centro del suo campo visivo, è la realtà. La realtà materiale, concreta, fisica, ma anche la realtà delle idee, concetti, paure, desideri, pulsioni, principi. Un oggetto quindi fisico, ma anche metafisico, che va quindi al di là della natura e ci porta nelle dimensioni di intelletto, pensiero, emozioni, etica, sogno. L'arte diventa così un mezzo di trasporto che ci conduce nelle più diverse direzioni trasfigurandole, rappresentandole quindi in modo simbolico, deformato, destrutturato e poi ricostruito, attraverso associazioni, relazioni, simultaneità, contrasti. L'opera è una narrazione visiva, tattile, uditiva - verbalizzata o no - della realtà; supera se stessa, la propria materialità, le forme, le tecniche che hanno condotto alla sua creazione per aprire squarci su mondi non attesi, proprio come in una delle Attese di Lucio Fontana. L'arte è un tramite costante tra la realtà esterna, l'interiorità dell'artista e quella del suo consumatore. Uso di proposito il termine consumatore perché l'opera va consumata per consentirle di esprimere tutto il suo contenuto: non basta osservarla; va vissuta più volte, gustata, esplorata.
L'appunto di Giacometti invece ci trasmette l'idea affascinante di un'arte da imparare a capire, a usare, per vedere la realtà. L'oggetto dell'arte, il centro del suo campo visivo, è la realtà. La realtà materiale, concreta, fisica, ma anche la realtà delle idee, concetti, paure, desideri, pulsioni, principi. Un oggetto quindi fisico, ma anche metafisico, che va quindi al di là della natura e ci porta nelle dimensioni di intelletto, pensiero, emozioni, etica, sogno. L'arte diventa così un mezzo di trasporto che ci conduce nelle più diverse direzioni trasfigurandole, rappresentandole quindi in modo simbolico, deformato, destrutturato e poi ricostruito, attraverso associazioni, relazioni, simultaneità, contrasti. L'opera è una narrazione visiva, tattile, uditiva - verbalizzata o no - della realtà; supera se stessa, la propria materialità, le forme, le tecniche che hanno condotto alla sua creazione per aprire squarci su mondi non attesi, proprio come in una delle Attese di Lucio Fontana. L'arte è un tramite costante tra la realtà esterna, l'interiorità dell'artista e quella del suo consumatore. Uso di proposito il termine consumatore perché l'opera va consumata per consentirle di esprimere tutto il suo contenuto: non basta osservarla; va vissuta più volte, gustata, esplorata.
Se l'oggetto dell'arte come "mezzo per vedere" è la realtà esterna, interna e immaginata, i soggetti sono invece almeno due: l'artista e il consumatore. L'artista "vede" attraverso la propria arte, concretizza la propria realtà interiore su una tela, si coglie attraverso lo spazio bidimensionale su cui mette le mani: come Narciso nello specchio d'acqua, con la differenza che l'immagine riflessa è quella che l'autore ha voluto o cercato di creare.
Il consumatore è in una posizione privilegiata perché non solo può vedere che cosa l'artista vuole esprimere e come, ma ha modo anche di dialogare con se stesso, di prendere parte a una rappresentazione che va oltre le intenzioni e le capacità dell'artista. La relazione tra consumatore e opera ad un certo punto diventa totalmente autonoma e altra rispetto a quella tra l'artista e la sua opera. L'opera stessa, quindi, prende una vita autonoma rispetto a quella che il suo creatore ha pensato di darle.
Se l'arte è in grado di dire molte più cose di quelle che il suo autore ha inteso, se parla direttamente all'osservatore e si offre a lui fino a farlo diventare consumatore, se tende a farsi possedere, diventa inevitabile cogliere la dimensione trasformatrice dell'opera. L'opera d'arte induce cambiamenti, trasformazioni, trans-formazioni, cioè modella il consumatore a diventare altro da sé, a subire una piccola - o grande - metamorfosi; l'arte pertanto diventa strumento di formazione, capace di plasmare l'osservatore facendolo diventare una tela su cui stendere nuovi colori o il blocco di marmo da cui liberare - rimuovendo l'inutile - la parte di sé in esso nascosta. Formazione significa partecipare al processo di acquisizione di una forma, facilitandolo, guidandolo, indirizzandolo.
Il processo di formazione avviene all'interno dell'osservatore: l'opera, per assumere un significato, per scatenare la sua forza evocativa e descrittiva ha bisogno di uno spettatore che abbia un ruolo attivo, che si lasci penetrare, non opponendo resistenze. È nello spettatore che non teme l'ignoto, l'insolito, l'incomprensibile, che l'arte può liberare le sue potenzialità generatrici di idee, riflessioni, decisioni e cambiamenti.
Perché avvenga il passaggio da ruolo passivo ad attivo, da spettatore a consumatore, è innanzitutto necessario che ci sia un contatto diretto con l'opera non mediato da fotografie, film o riproduzioni. Questa relazione in formazione deve essere guidata da un atteggiamento curioso da parte del consumatore; l'arte - diceva Berger - deve avviare un processo di interrogazione, una ricerca - potrebbe aggiungere - a più livelli in sovrapposizione: che cosa esprime l'opera, quali sono le intenzioni dell'artista, che reazioni suscita nello spettatore. Per poter dare una risposta a queste domande, lo spettatore/consumatore deve allenarsi con l'immaginazione e pensare di essere l'autore o un soggetto dell'opera che ha davanti a sé, un colore o la tela in pittura, uno strumento musicale in una sinfonia, un blocco di marmo nella scultura. Sentire le mani dell'artista che lo plasmano, lo suonano o lo distribuiscono sulla tela; cercare di immaginarne le sensazioni tattili, gli odori, le consistenze della materia, le temperature, i gesti preparatori o quelli creatori, il tempo necessario, le attese prima di mettere mano a questo o quel particolare. Nel fare tutto questo occorre porre la propria attenzione alle sensazioni, alle emozioni positive e negative, alle forze che attraggono e quelle che respingono e persino al rimanere indifferenti davanti a un'opera. Come mai siamo apparentemente sordi a quel che l'artista voleva dirci? Perché la sua opera sembra ignorarci, non essere interessata a noi, sembra non voler trasmetterci nulla?
Una successiva riflessione deve portare a pensare in quali altre circostanze della vita lo spettatore fa la stessa esperienza di pienezza o di vuoto, presenza o mancanza di significato e quali elementi possano essere in comune con la relazione che egli sta stabilendo con l'opera: perché l'opera lo cattura, lo fa suo? Perché invece sembra rifiutargli una qualsiasi possibilità di comunicazione? Quando nella vita quotidiana si può accorgere di attraversare le stesse sensazioni?
Come in tutte le cose, per far parlare un'opera ed essere in grado di ascoltarla occorre silenzio, concentrazione, sensibilità e attenzione e allenamento. L'opera deve avere il tempo di distrarci, condurci via dalla banalità e chiusura dei soliti pensieri e farci volare attraverso territori inesplorati e spesso scomodi. Non serve una competenza di natura artistica o filosofica: serve invece disponibilità ad ascoltare se stessi attraverso le opere.
 |
| Valentina Canale - Rami |
mercoledì 15 aprile 2015
LinkedIn: il conformismo e il niente
LinkedIn è un nonluogo meraviglioso. Viene usato per presentarsi, ma senza esporsi. Non una presa di posizione, tutto in guanti bianchi, per non urtare, solo convincere, persuadere, rendersi appetibili, ma non troppo saporiti. Un pizzico di banalità qua, una nuance di originalità là, tutto pulito, profumato con quella nota tipica dei deodoranti da bagno.
Un nonluogo fatto apposta per non sembrare troppo di niente. E a furia di non sembrare troppo di niente si finisce per essere quel niente.
Mi si chiede che cosa si possa fare per dare un po' di sangue, proteine e vitamine a questo corpo anemico che, attraverso un social, diventa la metafora perfetta di molti rapporti di lavoro, l'atteggiamento più promosso e diffuso nelle aziende.
Credo in passato di aver fatto la mia parte nell'oppormi a un certo andazzo tanto da essere considerato un paria ormai da molti, colleghi esimi compresi. Continuo a non farmi dire che cosa devo pensare, dire e fare, da nessuno. Se devo proprio sbagliare, sbaglio da me, grazie. Dire di sì quando è sì e di no quando è no - o "forse" se si ritiene giusto sospendere il giudizio - è un buon modo per sottrarsi alla metamorfosi ovina. E comunque essere disposti a pagare sempre in prima persona.
Non credo si possa fare molto di più di denunciare il conformismo e la mancanza totale di riflessione critica che sembra una specialità del sistema italia, così mafioso e feudale dacorrompere anche multinazionali che in patria operano con maggiore spirito autocritico e apertura alle differenze. Il sistema Italia trova invece adeguate stampelle anche presso impresentabili società di consulenza e formazione. Non impresentabili in quanto a conoscenze, esperienza o competenze, ma per mancanza di responsabilità (nel senso di accountability e responsibility) e di moralità che fa sì che altrimenti stimabili colleghi si uniformino senza discutere e accolgano solo un po' a malincuore - ma neanche poi troppo - procedure e buone pratiche che di improprio non hanno solo l'aggettivo. Tuttavia, si sa, "le cose vanno così". Ed è per questo che le colleghe del parco Trenno mi sembrano sempre un esempio di maggiore integrità e rettitudine.
Certo che se attorno a un tavolo o in un'aula censuriamo noi stessi per convenienza - "questo non si può dire, questo non si può fare, quest'altro è davvero troppo..." - non riusciremo mai a cambiare nulla, anzi rafforziamo lo status quo. Non si va in azienda a fare i predicatori - ce ne sono e dio ce ne scampi e liberi - ma neanche i galoppini o, peggio, i complici. Sennò hai voglia a portare l'arte contemporanea nelle organizzazioni come leva del cambiamento come cerco di fare, senza gran successo: anche l'arte infatti in molte circostanze ha blandito il potere e non ne ha mostrato affatto "di che lagrime grondi e di che sangue", ma l'ha celebrato e perpetuato. Non diversamente da formatori e consulenti.
mercoledì 25 marzo 2015
Giacometti o dell'organizzazione - 3
 Giunge alla sua ultima tappa, forse, il nostro percorso
in compagnia dell'opera di Alberto Giacometti. Negli articoli precedenti
abbiamo parlato dell'apparente continua insoddisfazione dell'artista davanti
alla sua opera, il bisogno incessante di doverla modificare, plasmare in una
tensione espressiva che sembra non riuscire mai a trovare compimento, a far
emergere una verità
interiore complessa e magmatica che vediamo increspare la superficie delle sue
sculture.
Giunge alla sua ultima tappa, forse, il nostro percorso
in compagnia dell'opera di Alberto Giacometti. Negli articoli precedenti
abbiamo parlato dell'apparente continua insoddisfazione dell'artista davanti
alla sua opera, il bisogno incessante di doverla modificare, plasmare in una
tensione espressiva che sembra non riuscire mai a trovare compimento, a far
emergere una verità
interiore complessa e magmatica che vediamo increspare la superficie delle sue
sculture.
Un'opera essenzialmente imperfetta, in senso etimologico,
non portata a termine, che non trova definizione, confini. L'imperfezione è la condizione necessaria per qualsiasi cambiamento: non c'è miglioramento senza
imperfezione. La perfezione invece è
il coronamento di un processo di creazione che non può più essere diverso da quello
che è, non può più arricchirsi, integrarsi. È compiuto e nel suo
compimento è depauperato di
qualsiasi potenzialità
alternativa. Può solo
distruggersi, annullarsi, perdere qualsiasi senso nella sua perfezione statica
perché il senso, la
direzione, il significato sono termini relativi che rimandano ad altro. Sono
tappe, passaggi, pietre miliari lungo un cammino. Non trovano spazio nella perfezione,
nella perfezione tutto si ferma e finisce.
Cambiamento, miglioramento, evoluzione vivono di
imperfezioni. Se ci lasciamo trascinare dall'opera di Giacometti e portiamo
l'attenzione alle organizzazioni e alle imprese ci rendiamo conto
dell'importanza dell'imperfezione per la sopravvivenza di quelle realtà. Non esiste mai un modello organizzativo
perfetto, esiste invece un sovrapporsi di imperfezioni in costante dialogo. Un
modello astratto non trova mai realizzazione: un'organizzazione è sempre il risultato in
fieri di infinite dinamiche che si integrano, si combattono, si selezionano.
Organizzazione deriva dal latino organum, strumento, mezzo.
L'organizzazione è lo strumento con
cui gli uomini realizzano un risultato, l'organizzazione quindi incide sul
risultato da realizzare, non è
una distribuzione di potere e funzioni. Organum deriva dal greco èrgon che significa lavoro. L'organizzazione è uno strumento di lavoro, un
mezzo finalizzato alla collaborazione delle persone, non un santuario dove si
celebrano le stratificazioni del potere e della gerarchia. È un costante tentativo di
raggiungere e migliorare un obiettivo condiviso. L'organizzazione è pertanto in sé giacomettiana, in costante
divenire, una tensione creatrice collettiva dove migliaia di dita plasmano
l'opera. Non può essere - e non è mai, in realtà - imposta dall'alto: è un costante processo
negoziale in buona parte inespresso, latente, generato dall'interdipendenza dei
comportamenti e dal fatto stesso di essere parte di un'organizzazione o
occupare uno spazio in un ufficio.
 Non ha alcun senso imbrigliare una realtà dinamica in ruoli
predefiniti; essa va lasciata pulsare, ribollire, occorre darle sfogo, lasciarla
modificare e fluire: procedure, schemi, pianificazioni rigide sono ostacoli
alla capacità generatrice
dell'organizzazione, ne impediscono la crescita, l'espressione di tutte le sue
potenzialità innovatrici.
Non ha alcun senso imbrigliare una realtà dinamica in ruoli
predefiniti; essa va lasciata pulsare, ribollire, occorre darle sfogo, lasciarla
modificare e fluire: procedure, schemi, pianificazioni rigide sono ostacoli
alla capacità generatrice
dell'organizzazione, ne impediscono la crescita, l'espressione di tutte le sue
potenzialità innovatrici.
Ecco quindi che l'arte di Giacometti ci richiama a riflettere sulla dimensione delle nostre esistenze come hommes
qui marchent anche in quei contesti in cui crediamo - o speriamo - che la
nostra libertà e la nostra
responsabilità non abbiano modo
di dispiegarsi nella loro più
ricca pienezza o in cui, più
semplicemente, temiamo di doverne prendere atto e operare di conseguenza.
venerdì 20 febbraio 2015
Rifrazioni giacomettiane - 2
 Nello stesso modo in cui, forse, si può considerare incompiuta tutta l'opera di Alberto Giacometti - appare come puro anelito, tentativo, aspirazione in costante svolgimento - credo di avere lasciato a metà anche le riflessioni che ho tentato di fare nell'articolo precedente. "Tentato", appunto, perché di Giacometti
Nello stesso modo in cui, forse, si può considerare incompiuta tutta l'opera di Alberto Giacometti - appare come puro anelito, tentativo, aspirazione in costante svolgimento - credo di avere lasciato a metà anche le riflessioni che ho tentato di fare nell'articolo precedente. "Tentato", appunto, perché di Giacomettisi può solo tentare di discutere. "Riflessioni" inoltre non sembra essere il termine più adatto: troppo pomposo per riferirsi a un autore scarno, nel fisico e nel lavoro, nodoso, immagine di quegli alberi antichi del paesaggio dei Grigioni che gli ha dato i natali. Forse sarebbe più adatto "rifrazioni": un fascio luminoso che si frange e si rifrange perché di Giacometti non si può mai finire di parlare; ogni elaborazione diviene magmatica, procellosa, non definibile.
È presente un continuo dinamismo nelle sue sculture, un movimento sia del soggetto rappresentato sia della materia che lo costituisce: l'homme qui marche, marcia, cammina verso di noi, non sta fermo, ha il passo deciso, costante del contadino montanaro. Un passo che non esprime incertezza, semmai prudenza. È il passo "non più lungo della gamba" che l'uomo concretamente attaccato alla terra sa di dover fare per rimanere al mondo, ma non fermo nel mondo. Pertanto eretto, decoroso, non fiero, la fierezza non è un sostantivo che si adatta all'uomo giacomettiano così intimo, profondo, che si proietta su una dimensione a cui non appartiene la retorica.
 La materia stessa è movimento incessante, frutto degli infiniti tentativi di dita ossute come rami di darle una forma definitiva, ultimativa. Una superficie increspata da chissà quali abitudini, turbamenti, pensieri, venti del desiderio e delle angosce. Giacometti sembra voler costantemente rappresentare una verità in divenire che prende e cambia forma sotto le sue mani, davanti ai suoi occhi. Una realtà di cui egli stesso non conosce la natura, ne coglie solo il bisogno di esprimersi: una realtà che produce il suo stupore, che è sempre nuova ai suoi occhi e non afferrabile. Una realtà che è una sfida costante, una messa alla prova.
La materia stessa è movimento incessante, frutto degli infiniti tentativi di dita ossute come rami di darle una forma definitiva, ultimativa. Una superficie increspata da chissà quali abitudini, turbamenti, pensieri, venti del desiderio e delle angosce. Giacometti sembra voler costantemente rappresentare una verità in divenire che prende e cambia forma sotto le sue mani, davanti ai suoi occhi. Una realtà di cui egli stesso non conosce la natura, ne coglie solo il bisogno di esprimersi: una realtà che produce il suo stupore, che è sempre nuova ai suoi occhi e non afferrabile. Una realtà che è una sfida costante, una messa alla prova.
Una domanda che l'osservatore non può fare a meno di porsi è pertanto quanto l'opera di Giacometti rifletta la personalità del suo autore: in che misura la sua dimensione del fare contenga la dimensione dell'essere. Una domanda che invero può essere rivolta all'opera di qualsiasi artista, ma che in Giacometti sembra essere suggerita con un tono di voce più udibile e ineludibile.
Da quello che abbiamo visto e ci siamo detti, si potrebbe concludere che le intenzioni di Giacometti sfuggano all'artista e che non sia capace di rappresentare in toto materialmente le proprie visioni e intuizi
oni, vinto da un'ansia che non gli dà tregua, lo perseguita e lo incarcera, mettendolo difronte ai propri limiti umani e artistici. Lo possiede un'ambizione troppo grande per le sue capacità o forse per le capacità di qualunque artista: la rappresentazione della condizione umana.
oni, vinto da un'ansia che non gli dà tregua, lo perseguita e lo incarcera, mettendolo difronte ai propri limiti umani e artistici. Lo possiede un'ambizione troppo grande per le sue capacità o forse per le capacità di qualunque artista: la rappresentazione della condizione umana.
Questa incapacità, questa condizione esistenziale come "essenza mancante" tuttavia emerge evidente: l'opera esprime totalmente la sua ansia, la sua minorazione rispetto alle intuizioni, ai richiami a qualcosa di più universale e profondo.
Ne consegue poi un'altra domanda: quanto le sculture di Giacometti, nel rappresentare la sua inadeguatezza rispetto ai bagliori di una realtà più grande, siano in grado di contenere tutta l'imperfezione dell'artista. Espresso in altri termini, data l'imperfezione e la costante mancanza di compimento della sua arte, quanto questa mancanza in realtà esaurisce tutto quello che Giacometti è capace di dire e di fare? Abbiamo forse arbitrariamente concluso che l'autore non riesce a esprimere quello che vuole, ma ci chiediamo se egli esprima in questa "lacuna" tutto se stesso o ci sia dell'altro che non vediamo perché non si è materializzato, non ha trovato vita nell'espressione figurativa.
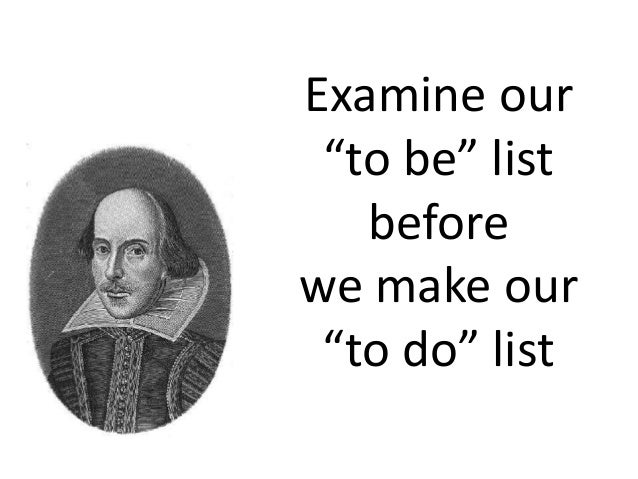 Nell'accademico dialogo tra fare ed essere siamo in questo caso indotti a pensare che il fare non esaurisca l'essere, che Giacometti cioè trascenda la sua opera. Niente infatti ci viene detto dei gesti scartati, della materia buttata, del processo di selezione, di tutto quello che non andava bene al vaglio dell'occhio e del cuore dell'artista. Non sappiamo nulla dei suoi "rifiuti", di quel che non riteneva degno di ulteriori tentativi, ma di esclusione, cancellazione o rimodellamento. Un'opera artistica non è mai in grado di dirci nulla del processo complesso che ha portato alla sua realizzazione, ne vediamo infatti solo il risultato finale: non sappiamo nulla del momento dell'ideazione, dei ripensamenti, dello svolgersi del lavoro, delle costrizioni, delle modalità di scelta dei materiali, dei contributi eventualmente apportati da altri, dei contrasti, dell'ambiente che ne ha ispirato la realizzazione, l'ha condizionata o bloccata. Un'opera porta in sé la mancanza, l'abbandono di tutto quanto non era ancora se stessa. Si stacca dall'albero come un frutto e rotola lontano e non sappiamo più nulla dell'albero che l'ha generato, l'acqua, il sole, la terra che l'hanno fatto crescere. Molto è quindi lasciato all'immaginazione di noi osservatori, esperti o profani, a quello che l'opera riesce a ispirarci. L'interpretazione soggettiva ha il potere di trovare nutrimento non solo nelle eventuali conoscenze e competenze artistiche dell'osservatore, ma soprattutto nelle sue personali riflessioni ed emozioni che non di rado non hanno origine nel contatto con l'arte, ma che attraverso l'esperienza artistica trovano un nuovo significato, una nuova forma e diventano più pienamente comprensibili. L'arte diventa così strumento maieutico capace di far emergere e attribuire senso, valore, reinterpretando la propria esperienza esistenziale in modo più ampio e più ricco. L'opera di Giacometti, proprio per la sua indefinibilità fisica, materiale, i suoi confini aperti, la sua imperfezione e incompiutezza, sembra possedere un potere educativo - in senso etimologico, forse addirittura taumaturgico - ancora più forte, più imbrigliante l'attenzione e la sosta dello sguardo dell'osservatore su di essa.
Nell'accademico dialogo tra fare ed essere siamo in questo caso indotti a pensare che il fare non esaurisca l'essere, che Giacometti cioè trascenda la sua opera. Niente infatti ci viene detto dei gesti scartati, della materia buttata, del processo di selezione, di tutto quello che non andava bene al vaglio dell'occhio e del cuore dell'artista. Non sappiamo nulla dei suoi "rifiuti", di quel che non riteneva degno di ulteriori tentativi, ma di esclusione, cancellazione o rimodellamento. Un'opera artistica non è mai in grado di dirci nulla del processo complesso che ha portato alla sua realizzazione, ne vediamo infatti solo il risultato finale: non sappiamo nulla del momento dell'ideazione, dei ripensamenti, dello svolgersi del lavoro, delle costrizioni, delle modalità di scelta dei materiali, dei contributi eventualmente apportati da altri, dei contrasti, dell'ambiente che ne ha ispirato la realizzazione, l'ha condizionata o bloccata. Un'opera porta in sé la mancanza, l'abbandono di tutto quanto non era ancora se stessa. Si stacca dall'albero come un frutto e rotola lontano e non sappiamo più nulla dell'albero che l'ha generato, l'acqua, il sole, la terra che l'hanno fatto crescere. Molto è quindi lasciato all'immaginazione di noi osservatori, esperti o profani, a quello che l'opera riesce a ispirarci. L'interpretazione soggettiva ha il potere di trovare nutrimento non solo nelle eventuali conoscenze e competenze artistiche dell'osservatore, ma soprattutto nelle sue personali riflessioni ed emozioni che non di rado non hanno origine nel contatto con l'arte, ma che attraverso l'esperienza artistica trovano un nuovo significato, una nuova forma e diventano più pienamente comprensibili. L'arte diventa così strumento maieutico capace di far emergere e attribuire senso, valore, reinterpretando la propria esperienza esistenziale in modo più ampio e più ricco. L'opera di Giacometti, proprio per la sua indefinibilità fisica, materiale, i suoi confini aperti, la sua imperfezione e incompiutezza, sembra possedere un potere educativo - in senso etimologico, forse addirittura taumaturgico - ancora più forte, più imbrigliante l'attenzione e la sosta dello sguardo dell'osservatore su di essa. Un potere che induce a indagare oltre, a capire, a esplorare la metafisica dell'opera, ma anche ad approfondirne lo studio in un dominio che non è solo intellettuale, ma è attraversato dall'esperienza personale vissuta dal soggetto, diventando per lui profondamente e diversamente simbolico ed evocativo.
Un potere che induce a indagare oltre, a capire, a esplorare la metafisica dell'opera, ma anche ad approfondirne lo studio in un dominio che non è solo intellettuale, ma è attraversato dall'esperienza personale vissuta dal soggetto, diventando per lui profondamente e diversamente simbolico ed evocativo.
Per questo credo che Alberto Giacometti sia un artista che possa dare infinite suggestioni da cui trarre ispirazione in diversi contesti e segmentazioni della vita di ognuno di noi e che cercherò di affrontare in un prossimo articolo in cui cercherò di contrapporre sete di perfezione e bisogno di cambiamento. Se non vi darà noia.
Iscriviti a:
Post (Atom)









