
Una povera mostra a Milano su Giacometti è stata l'occasione per qualche riflessione sul fare, il lavoro, il creare un'opera indipendentemente dalla natura dell'opera stessa: una scultura - come nel caso di Giacometti - un'auto, un oggetto qualsiasi o un documento, relazione, grafico.
Le riflessioni, se così pomposamente vogliamo chiamarle, sono state ispirate sia dalle opere dell'artista grigionese sia dal suo percorso intellettuale e artistico e non ultimi da alcuni aspetti della psicologia di Giacometti che sembrano emergere dalle sue figure.
Innanzitutto, che cosa stavo cercando? Nulla, solo un po' di ispirazione perché sono convinto che l'arte abbia il potere di far nascere pensieri, suscitare emozioni contrastanti. Anche quando non la si capisce; soprattutto forse quando non la si capisce. Non credo di avere mai capito Giacometti e forse non l'ho capito neppure ora. Mi interessa solo ragionare su quello che ho visto.

Pensare a Giacometti significa per me pensare a immagini, proiezioni plastiche verticali, che si stagliano in uno spazio vuoto facendone da cesura: sembrano imporsi nella loro fragilità e sembrano depositarie di un mistero che non si riesce a cogliere. Ricordano quelle figure bronzee etrusche come la cosiddetta "Ombra della Sera" di Volterra (immagine a destra). Certamente l'arte etrusca ha influenzato l'opera di Giacometti, fin dalle sue prime teste che tuttavia trovo abbiano poca carica evocativa. Mentre impressionante è la sua capacità di farle rivivere nelle sculture delle figure umane.
L'artista svizzero ha subito suo malgrado parecchie etichettature: quella
stucchevole abitudine intellettuale che tende a imprigionare qualsiasi manifestazione della cultura all'interno di categorie precostituite che semplificano e impoveriscono la portata degli artisti migliori, arricchiscono
quella dei peggiori e affratellano tra loro chi non ha alcuna relazione di parentela. Sono esercizi di menti pigre, spaventate dal nuovo e dall'ignoto e bisognose di classificare e ridurre tutto a una realtà nota perché è un modo come un altro per esercitare il proprio potere nelle accademie, sui giornali, nei ministeri, nei mercati. Giacometti fu considerato cubista, surrealista e da ultimo, da quel gran sacerdote della filosofia francese moderna, J.P. Sartre, esistenzialista. Giacometti rifiutava tutte queste gabbie concettuali che hanno l'unico merito di evidenziare il tortuoso percorso esistenziale del grigionese. Un continuo attraversare i significati, le interpretazioni, le diverse modalità espressive. Una costante mancanza di definizione ultima, un mutamento continuo, mai compiuto, mai perfetto, mai approdato. Provo molto turbamento nell'accostarmi alla materializzazione di tutta questa insoddisfazione palpabile per l'opera compiuta. Forse addirittura per le proprie capacità di artista, quel che sa fare, quel che è. Una continua apparente tensione verso quel che non riesce mai a essere.
Mi soffermo sulle tante versioni de l'"Homme qui marche", di cui neanche una era presente alla mostra milanese. Povera per numero delle opere, misera per i contenuti didattici e gli allestimenti.
L'uomo che marcia, gli uomini che marciano, sculture lunghe, strette, che appaiono ancora più lunghe di quello che sono. Sembrano appartenere a uno spazio metafisico, che non è il nostro. Possiamo girare loro intorno, ma loro sono altrove, dove noi non riusciamo a essere. Ci rappresentano nella nostra incompletezza, ma a differenza di noi sembrano capaci di proiettarsi in avanti, venirci incontro ignorandoci. Hanno la sconvolgente caratteristica contraddittoria di una fissità dinamica. Separano il loro spazio dal nostro, come confini, come esili colonne d'Ercole della nostra esistenza. Simultaneamente, tenendoci distanti, a una distanza esistenziale, in una quarta dimensione in cui poterci specchiare, ci rappresentano, si impongono alla nostra attenzione, ci turb
ano, ci parlano di noi, convergenze di tutte le nostre esperienze e attimi di vita. Lo fanno con la loro totale mancanza di realismo e di naturalismo: sembrano proiezioni, senza sguardi, senza lineamenti, senza forme definite. Sono raccolte di gesti manuali, cenni mentali. La loro superficie è un campo indefinito di impronte di dita incapaci di fermarsi, bisognose di plasmare, riplasmare, toccare, modellare, rimodellare senza sosta perché quella cavità non va più bene, quel rigonfiamento ha perso il suo senso nel momento stesso in cui andava formandosi sotto i polpastrelli. Una superficie che è un mare mai fermo, un dinamismo incessante che contrasta con la staticità di noi che guardiamo, giriamo loro intorno, furtivamente le tocchiamo. Come uno scrittore passa in rassegna decine di parole per cercare l'unica che soddisfa il suo desiderio di esprimersi, così Giacometti sembra selezionare i movimenti delle mani, non riuscendo mai a trovare quello che corrisponde pienamente a quel che vuol rappresentare. È sintomo di incapacità di esprimersi questa continua cancellazione e ricerca di gesti o è piuttosto un modo per cercare di catturare la realtà che, per sua natura, è in costante mutazione? Osservi e quel che osservi si modifica proprio a causa della tua osservazione, hanno scoperto i fisici quantistici contemporanei di Giacometti. Egli coglie il divenire che la nostra staticità mentale non riesce a percepire. Afferra il momento e lo proietta sul piano del destino delle nostre esistenze. Le opere non sembrano quindi essere attraversate da una tensione verso il bello, l'armonia, il piacere estetico. Piuttosto, dalla disperazione nella capacità di rappresentare una realtà apparentemente senza possibilità di compimento. Non una proiezione verso la perfezione, l'opera compiuta, michelangiolesca, ma l'angosciante aspirazione a rappresentare la condizione umana.
.jpg)
Se l'uomo sembra non poter essere definitivamente rappresentato, descritto, raccontato, se non per infinite approssimazioni, questa non riproducibilità figura
tiva ricorda molto da vicino l'ineffabilità del divino. Un divino che è come impura imperfezione.
Cosa possiamo trovare muovendoci un po' al di là del nostro rapporto diretto con l'opera dell'artista e del riscontro della nostra immaginazione, pensieri ed emozioni rispetto ad essa? Innanzitutto, la difficoltà di capire la realtà nella sua completezza e complessità. Un'esperienza che facciamo quotidianamente, ma che risolviamo con un gesto di presunzione di comprensione che ci fa perdere dettagli, sostanza, significati e ce ne fa cogliere solo alcuni e attribuirne arbitrariamente altri. Dovremmo forse essere più consapevoli che qualsiasi tentativo di interpretazione delle realtà, degli uomini, dei comportamenti sia solo un insieme ridotto di approssimazioni. Una modellizzazione, appunto, non esaustiva e non generalizzabile.
Inoltre, la storia stessa di Giacometti, il suo percorso intellettuale, ci devono aiutare a capire che le abituali categorie con cui analizziamo e cataloghiamo il mondo non sono adatte per il nuovo che emerge dall'ordinario: non sono adatte perché riducono il non conosciuto al già noto e non sono adatte perché sono statiche, non dinamiche, hanno i confini rigidi, frontiere presidiate, non evolvono, non si liquefano scorrendo lungo i vari rivoli del sapere. Tendono piuttosto ad arginare esperienze e conoscenze. Ecco quindi che Giacometti non è abbastanza cubista né surrealista né esistenzialista. Giacometti - secondo questa comune attività riduzionista - non può essere letto come Giacometti e basta, ma deve essere ricondotto a qualcos'altro, un sé più povero, ma più facilmente conoscibile, dominabile. Quante volte facciamo lo stesso esercizio con chi abbiamo intorno, chi collabora con noi, i nostri familiari, in un tentativo di addomesticamento della realtà. Quante volte il nuovo ci fa talmente paura, ci disorienta a tal punto da spingerci a rinominarlo con un nome già usato e abusato, ad assimilare i non simili perché così facendo non ci sentiamo esclusi dai nuovi processi che prendono vita intorno a noi.
Il disagio, l'ostacolo della non omologabilità de l' "Homme qui marche", l'uomo che cammina lungo direzioni che non sono quelle che abbiamo pensato e progettato per lui: l'uomo che nella sua imperfezione, nella sua incompletezza, mostra il palpito silenzioso della propria libertà e originalità e si impone alla nostra coscienza. Invece di coglierne la ricchezza, le potenzialità inespresse o in formazione, invece di riscoprire in noi stessi le sue infinite dialettiche, ne siamo disturbati, lo vorremmo fermo, ben identificato, chino sui suoi compitini, ingranaggio della macchina organizzativa di cui siamo vittime e artefici.

Qualsiasi anelito alla perfezione sembra coincidere con la pretesa di decidere di porre fine a un processo in evoluzione a un certo "punto fermo" del suo sviluppo. Sono i nostri limiti cognitivi e interpretativi - e la nostra ambizione - che lo hanno fissato d'imperio perché appagante, in quanto corrispondente al bisogno di credere in una perfezione per sottrarci alla responsabilità di affrontare un divenire continuo, spaventati dalla nostra e dall'altrui libertà.









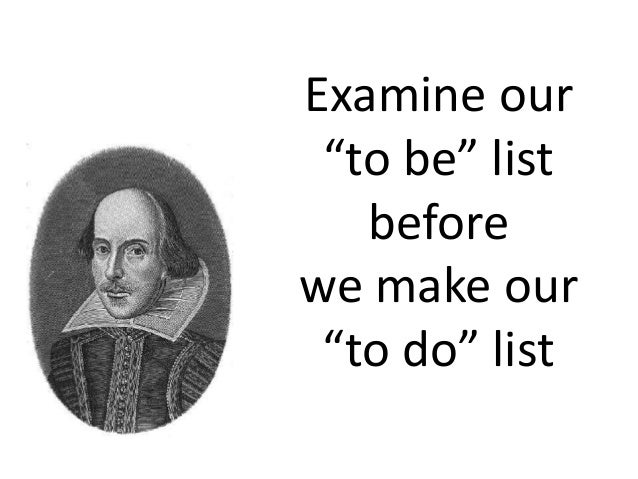



.jpg)
